Storia del Casoncello
Il casoncello è un piatto tipico lombardo, diffuso soprattutto tra Bergamo e Brescia. Si riconosce per la forma a caramella, il ripieno vario che unisce spesso dolce e salato, e le numerose varianti che cambiano di luogo in luogo.
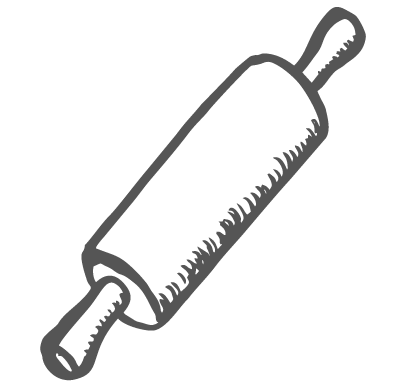
Le sue varianti sono innumerevoli ed ogni famiglia tramanda la propria ricetta di generazione in generazione. Il ripieno, oggi, è di carne. Ma, specialmente nel passato, poteva contenere erbe, formaggio ed una grande quantità di spezie. È importante sottolineare che il contenuto del ripieno dipendeva molto anche dal luogo in cui venivano preparati i casoncelli: in montagna, per esempio, solitamente era di magro. Ma, soprattutto, ognuno nel ripieno metteva quello che aveva!
Il casoncello nacque nel Medioevo, come testimoniano numerosi manoscritti del Trecento, e la sua lontana origine si avverte, ancora oggi, nel gusto tipicamente agrodolce. In quell’epoca, infatti, il raviolo bergamasco prevedeva al suo interno frutta o marmellata, veniva fritto nell’olio e servito con una spolverata di zucchero¹.
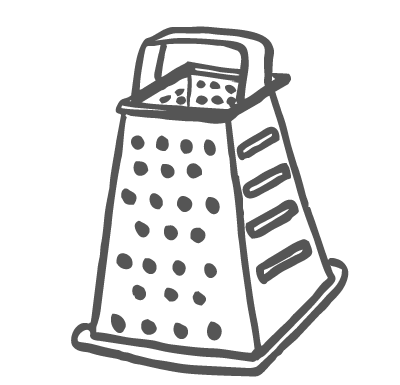
La peculiarità dei Casonsèi de la Bergamasca, secondo il disciplinare di produzione, è il lieve contrasto tra il sapore dolce dell’uvetta e delle pere (Abate in autunno e inverno, Spadona in primavera e estate) e quello amaro degli amaretti. Secondo una leggenda popolare, la presenza del sapore zuccherato e di quello sapido all’interno dello stesso piatto è da attribuire ad un uomo molto avaro che, per risparmiare sul pranzo da offrire ai suoi invitati e allo stesso tempo accontentare i gusti di ognuno di loro, volle unire in un’unica portata il dolce e il salato². Le fonti storiche che dimostrano la presenza del casoncello in territorio bergamasco nel Trecento ci raccontano alcune storie curiose³.
Negli anni ‘80 del XIV secolo, Bergamo era governata dal tirannico Bernabó Visconti. Ma nel 1385 suo nipote, Gian Galeazzo, lo catturò, facendosi poi proclamare Signore dì Milano e, quindi, anche del territorio bergamasco. I bergamaschi, esasperati dalle angherie di Bernabó, accolsero con gioia l’ingresso in città del nuovo comandante, tanto da offrire al Signore e ai suoi soldati trecento piatti da portata “tarlieros artibotulorum”, anche detti “casonzelorum”.
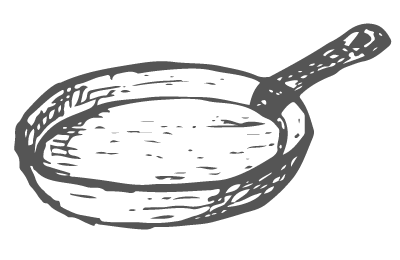
Il casoncello fu protagonista non solo di importanti avvenimenti politici, ma anche di intricate trame amorose. Correva l’anno 1393; il ghibellino e aristocratico Leonardino Suardi si invaghì della moglie di un contadino e, per averla per sé, assoldò un tale Tonolo di Stezzano e la moglie, i quali servirono al contadino dei casoncelli avvelenati, uccidendolo. Ma la congiura fu scoperta e si concluse con la decapitazione di Tonolo e l’allontanamento di Leonardino dalla città di Bergamo.
Dovete sapere, infine, che una delle fasi più importanti della sua lavorazione è la chiusura del raviolo, che deve dare ai casoncelli la caratteristica forma di curiose caramelle⁴.
Ora non vi resta che mangiarli, tenendo bene a mente un suggerimento di antica data: io ne tengo in ballo, per volta, non meno di nove. Tre in bocca, tre sotto la forchetta e tre intanto li faccio tremare con gli occhi⁵.

CASONSELLI ALLA BERGAMASCA
di Giovanni Felice Luraschi “Nuovo cuoco milanese economico, 1839
Prendete tre peri spadoni, pelateli e tagliateli a fettine, metteteli in una cassarola sopra un fornello, fateli cuocere mischiandoli con un cucchiaio di legno, pelate e mettete nel mortajo once tre di mandorle dolci, once tre cedrato, quattro amaretti ed una delle fettine dei detti peri, pestate il tutto insieme assai fino, dopo uniteci le fettine dei peri ristretti ed asciutti con due soldi di pane di semola grattato ed once tre di butirro, fate bollire tutto insieme e legatelo con un uovo intero, versatelo sopra d’un piatto e lasciatelo venir freddo. Prendete mezza libbra di farina di semola, mettetela sopra la tavola, fateci un buco nel mezzo, impastatele con acqua ben calda ma non bollente, manipolatela bene, ma fate che non sia ne troppo dura ne troppo morbida, con una cannella tiratela sottile come si constuma per i ravioli, e con un copa-pasta, o un bicchiero tagliatela ed in ogni pezzo mettetevi tanto come due nocciuole del suddetto pieno, doppiate e schiazati bene all’intorno, e fate che la pasta schizzata rimanga sotto e sopra, schizzate un poco con un dito in modo che formi mezzaluna: al momento che dovete farli cuocere allestite una cassarola con acqua salata, fateli cuocere, abbiate attenzione che in meno di un quarto d’ora sono cotti, poiché se lasciate passare la cottura si rompono: cotti levateli colla paletta, asciutti metteteli sopra un piatto piuttosto fonduto con sopra formaggio trido fino in abbondanza e butirro purgato, ma nel purgarlo non lasciategli prendere il nero, e servite all’istante.
1. https://www.bg.camcom.it/bergamo-citta-dei-millesapori/prodotti/primi-piatti/casoncelli
2. I. FORESTI, Cibo, terra e lavoro, Centro Studi Valle Imagna, S.l., 2017
3. https://www.bergamonews.it/wp-content/uploads/2017/05/Libretto-De-Casoncello-2016.pdf
4. C. STEINER, Il ghiottone lombardo, Edizione Bramante, Milano, 1964
5. P. FRATTINI, R. RAVANELLI, Il Novecento a Bergamo, cronache di un secolo, UTET, Novara, 2013
Ciao, io sono Valeria, e questi sono i miei casoncelli.
Li preparo con la stessa cura con cui li servirei a casa mia.
Ti va di assaggiarli?

CONTATTI
